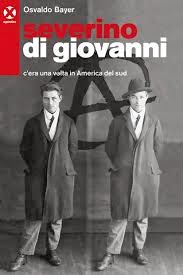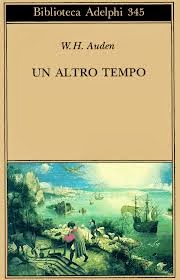Un libro può sopravvivere al suo autore, e anch'esso si muove, e si può anche dire che cambi, ma non allo stesso modo della narrazione orale. Cambia il modo in cui lo si legge.
Come hanno sottolineato molti critici, le opere letterarie sono ricreate da ciascuna generazione di lettori, che le rinnovano trovando in esse nuovi significati. Così il testo stampato di un libro è come una partitura musicale, che non è in sè musica, ma diventa musica quando è suonata - o "interpretata", come diciamo - da musicisti.
L'atto di leggere un testo è come suonare musica e ascoltarla allo stesso tempo, e il lettore diventa anche l'interprete.
(Margaret Atwood, Negoziando con le ombre, Ponte alle Grazie)
Come hanno sottolineato molti critici, le opere letterarie sono ricreate da ciascuna generazione di lettori, che le rinnovano trovando in esse nuovi significati. Così il testo stampato di un libro è come una partitura musicale, che non è in sè musica, ma diventa musica quando è suonata - o "interpretata", come diciamo - da musicisti.
L'atto di leggere un testo è come suonare musica e ascoltarla allo stesso tempo, e il lettore diventa anche l'interprete.
(Margaret Atwood, Negoziando con le ombre, Ponte alle Grazie)